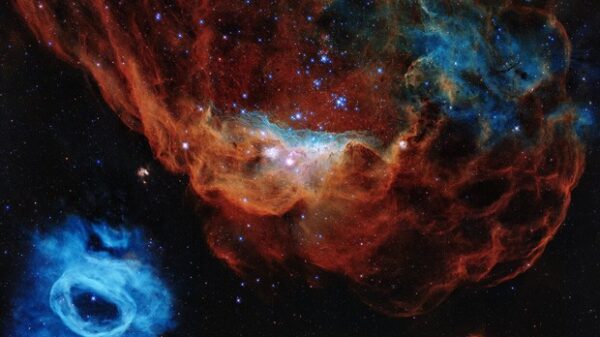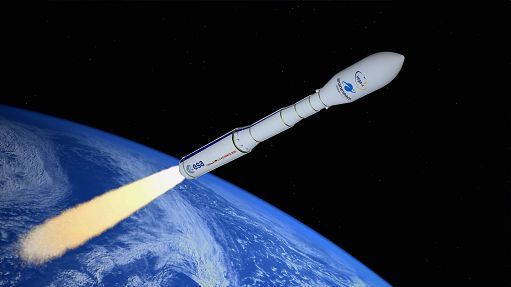«ADHD – Rush hour» è il primo lungometraggio della regista italiana Stella Savino. Un film-documentario che racconta come oggi venga diagnosticata e curata la sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
La regista spiega che il primo obiettivo del film non è «denunciare le case farmaceutiche ma far capire come sia difficile percepire questa problematica e come chi l’affronti sia lasciato solo». Infatti questo viaggio fra Europa e USA per documentare gli aspetti di questo disturbo comportamentale, che divide la comunità scientifica da più di cinquant’anni, non vuole dare risposte ma dar voce alle molteplici domande ancora senza risposta: le cause (perché una causa specifica non è ancora nota, quanto sia da attribuire ai geni e quanto all’ambiente), le cure (terapie comportamentali, interventi clinico-psicologici e sullo stile di vita, farmaci) e gli effetti collaterali dei medicinali. Stefano Canali, attualmente ricercatore in Storia della Scienza al Laboratorio Interdisciplinare della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste, dal 2008 nel direttivo della Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) e consulente scientifico durante la realizzazione del film, ha detto che «persino sulla diagnosi non ci sono certezze» perché viene effettuata semplicemente osservando il comportamento dei bambini e l’esistenza di eventuali problemi relazionali.
La cineasta napoletana in fase di preparazione aveva avuto modo di parlare anche con Giovanni Bollea, padre della moderna neuropsichiatria infantile morto nel 2011, che le aveva detto che il 90% dei casi era stato curato da lui mandando i bambini in bici con il proprio padre. Quindi l’approccio diagnostico e il conseguente approccio terapeutico dipende dal medico al quale viene affidato il paziente. Questa sindrome, considerata una anomalia neuro-chimica di origine genetica, è un disturbo del comportamento le cui caratteristiche sono iperattività motoria, impulsività, disattenzione, distrazione e questo documentario testimonia come il Paese nel quale si vive possa incidere sulla scelta della cura. Molte volte la cura consigliata è basata su farmaci stimolanti come il metilfenidato (contenuto nel Ritalin) che è una anfetamina, farmaci non stimolanti come l’atomoxetina, e antidepressivi. Gli effetti collaterali, che cambiano in base al principio attivo usato, a volte sono insostenibili: tendenze suicide (in Italia si sono tolti la vita dieci bambini su duemilacinquecento), infarto, alopecia e problemi epatici molto gravi. Negli Stati Uniti, dove la AHDH è stata diagnosticata anche ad un anno d’età, sette milioni di bambini (uno su cinque) vengono curati con il Ritalin, detta anche «pillola dell’obbedienza» perché rende calmi, più concentrati e tra i suoi effetti collaterali, oltre a dipendenza e depressione, c’è quello che viene chiamato «effetto zombie» perché oltre a calmare altera la personalità, annullando emotività e capacità creativa.
La situazione italiana non è ai livelli di quella americana. Qui il Ritalin è stato reintrodotto nel 2007 e la percentuale dei bambini affetti da questa sindrome, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, dove è stato istituito un registro nazionale per questo disturbo, non supera l’1%. Come spiega il professor Canali, «molto dipende dal contesto culturale e sociale in cui si vive: negli Stati Uniti c’è molta pressione anche sulla performance dei bambini ed è molto probabile che chi ha ricevuto questa diagnosi lì, in Italia non sarebbe considerato affetto da ADHD». In Italia inoltre ci sono circa novanta centri regionali dove si devono provare tutte le terapie comportamentali prima di quella farmacologica. L’ONU parla di emergenza sanitaria per quanto riguarda l’uso del metilfenidato che essendo una anfetamina è classificato dalla DEA (Drug Enforcement Administration) nel gruppo dei narcotici, con eroina, morfina e cocaina, invitando quindi le nazioni a frenare l’uso eccessivo di questo farmaco, valutando l’eventuale sovrastima di questo disturbo.
Le testimonianze di vita all’interno di «ADHD – Rush hour» sono tante. C’è Armando, un ragazzo romano di diciannove anni che frequenta la terza superiore, al quale hanno diagnosticato l’ADHD all’età di dieci anni, in cura farmacologica da nove. La madre andava in Svizzera a prendere i farmaci quando da noi non ne era autorizzata la vendita. Oggi è in grado di gestire la cura e ricorda come fosse l’unico bambino della sua classe alle elementari con il permesso di masticare la gomma americana per non disturbare gli altri con quei suoni strani che lui usava per ritrovare la concentrazione. Poi c’è Zache che di anni ne ha dieci, frequenta la quinta elementare e vive a Miami. La diagnosi già al primo anno di asilo e da quel momento non ha smesso di prendere farmaci, sperimentando tutti quelli indicati per questo disturbo perché ha un problema, li metabolizza troppo velocemente quindi l’insorgenza degli effetti collaterali è rapida. È iscritto ad un campo estivo per bambini affetti da ADHD, il Summer Treatment Program, nel quale gli insegnanti assegnano punteggi in base al comportamento. La diagnosi di questa sindrome, definita dall’American Psychiatric Association nel DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disordini Mentali) come tipica dell’età evolutiva, oggi riguarda però anche gli adulti. Lindsay, una ragazza laureata di venticinque anni che vive a New York, ha avuto la sua prima diagnosi a ventuno anni, quando era già adulta.
Si intuisce come questo disturbo sia in espansione e come questa espansione aumenti il mercato delle case farmaceutiche. Il documentario di Stella Savino, girato tra laboratori di genetica e tecniche di brain imaging, tra aule delle università e delle scuole elementari, vuole mettere a confronto le diverse esperienze dei medici, dei genitori e dei loro figli, invitando lo spettatore a riflettere e a giudicare la realtà dei fatti visti, come una porta aperta, come un punto di domanda che non lascia in pace: è una vera e propria malattia mentale o è reale il rischio di un abuso di farmaci in una società che vuole controllare comportamenti naturali dell’infanzia, interferendo chimicamente in questo modo con il naturale sviluppo di un bambino?