Intervista a Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra – Botta e risposta con il duo di architetti
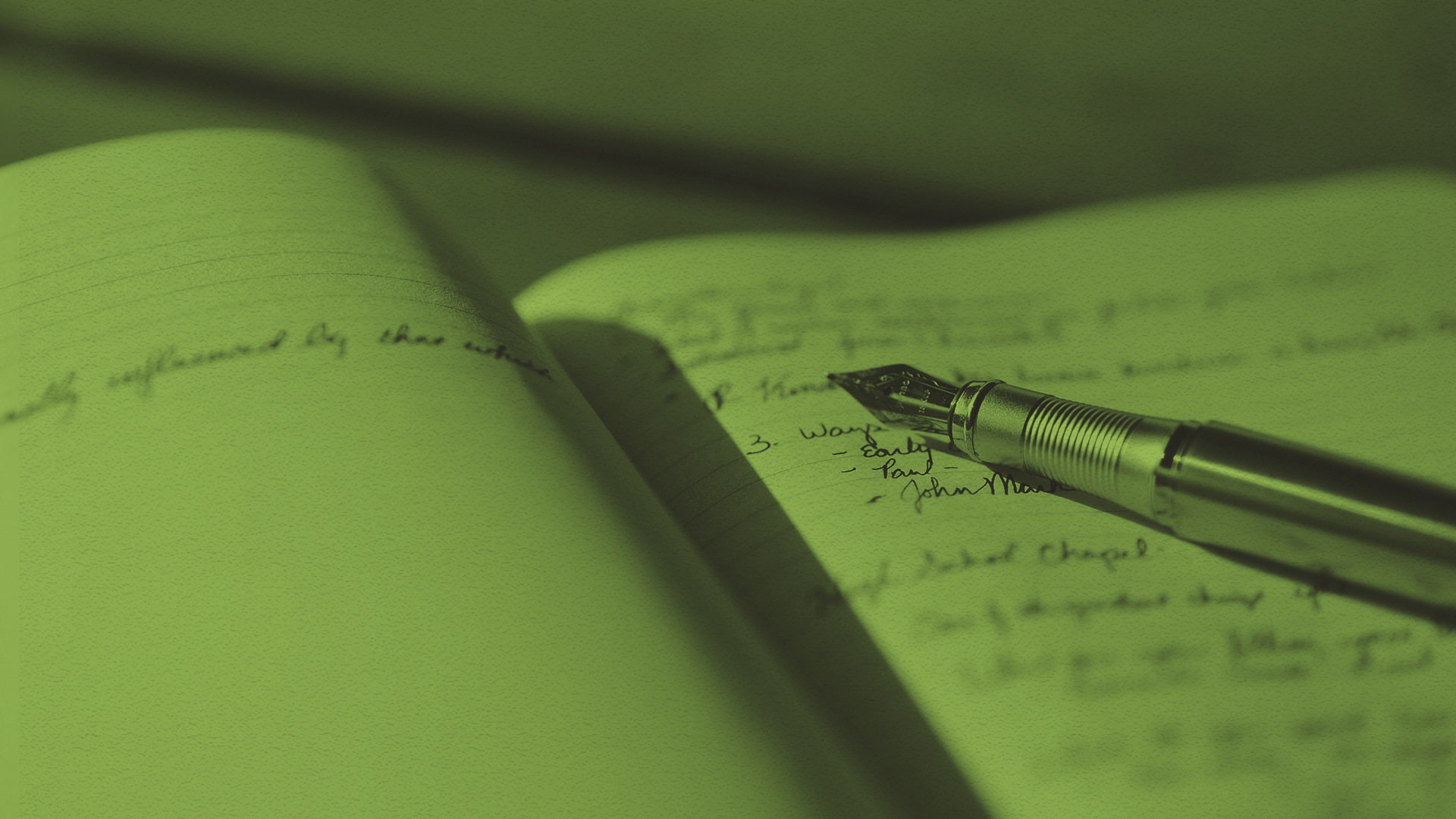

I protagonisti della chiacchierata di oggi sono Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra dello Studio Barreca e La Varra con cui ho collaborato nel mio soggiorno milanese. Lo studio nasce nel 2008 a Milano , e risulta attivo in campo nazionale e internazionale, dalla più piccola scala architettonica a quella urbana.
Aver avuto l’opportunità di lavorare con loro ha sicuramente arricchito il mio bagaglio e mi ha lasciato un buon ricordo, e questa intervista è un po’ il tributo che ho voluto dedicargli.
La cosa più affascinante che si legge sul loro sitoweb è che l’ ”architettura è addomesticabile”: ogni progetto ha una prima vita che va dalla sua concezione alla fine del cantiere ed una seconda una volta che questo eserciterà la sua funzione. La prima vita è abitata da tecnici, architetti, ingegneri, muratori, geologi … la seconda è popolata dalle persone più improbabili: la parte più imprevedibile e complessa.
Buona chiacchierata.

SF Con Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra) avete realizzato il celebre Bosco Verticale. – Le due torri per la città di Milano, realizzate da Hines Italia nell’area di recente riqualificazione Porta Nuova Isola, sono alte rispettivamente 80 m e 112 m, e sono caratterizzate da terrazze a sbalzo pensate per accogliere il corrispettivo.
di 10000 mq di bosco tra alberi di altezza e fioritura variabile e varie specie di arbusti. Il concept progettuale alla base è quello di ridefinire il rapporto tra natura e area metropolitana. (nda) – Cosa volete dirci in più a riguardo di tale progetto? Come si traduce il concept generativo in termini di sostenibilità?
B&LV Ci piace l’idea che Bosco Verticale sia un’architettura che demineralizza le superfici urbane. Questo attraverso uno schermo vegetale in grado di filtrare la luce e le polveri sottili. E generando un adeguato microclima che produce umidità e ossigeno, e assorbe CO2, oltre a funzionare come barriera per la polluzione acustica.
Si tratta di un approccio diverso dalla tradizionale sostenibilità ambientale basata sulla ricerca tecnologica e meccanica: un’architettura biologica che riscopre il valore naturalistico ed identificativo degli alberi. La scelta delle essenze è il risultato di due anni di studi in equipe con un gruppo di botanici.
Questa scelta infatti ha come valore aggiunto la creazione nuovi habitat biologici in città, favorendone la biodiversità.

Infine bisogna citare l’azione anti-sprawl e di densificazione urbana delle torri, in grado di accogliere una popolazione equivalente a quella di circa 50.000mq di ville monofamiliari e palazzine di una qualsiasi area periferica diffusa.
Ovviamente queste scelte progettuali portano con sé delle conseguenze sulla manutenzione e gestione dell’immobile. Le piante inserite nelle vasche sono pre-coltivate in vivaio al fine di configurarle come da progetto e la gestione e la manutenzione successiva di queste è condominiale. È inoltre stato studiato un sistema di irrigazione commisurato ai fabbisogni micro meteorologici differenziato per esposizione di facciata e distribuzione della vegetazione sul piano.
Recentemente Bosco Verticale è stato candidato all’ International Highrise Award 2014, un premio bandito dal Museo di Architettura di Francoforte che verrà assegnato il prossimo 19 novembre. Nella lista dei 5 grattacieli più belli e innovativi realizzati negli ultimi anni, oltre a Bosco ci sono il “De Rotterdam” di Rem Koolhaas, il “One Central Park” a Sydney e il “Reinassance Barcelona Fiera Hotel” di Jean Nouvel e lo “Sliced Porosity Block” di Steven Holl a Chengdu in Cina. (nda)

SF Sempre sul tema della sostenibilità, mi viene in mente il progetto per il piano urbanistico di iper-crescita della città di Khovd in Mongolia. Potete spiegarci un po’ il progetto e le linee guida in esso dettate?
B&LV Il progetto di questo masterplan nasce a seguito di un concorso indetto dal Ministero delle infrastrutture mongolo, per il rifacimento del Piano di Governo del Territorio di tutte le regioni della nazione. Abbiamo partecipato a 4 dei sette bandi indetti, e vinto quello per la città di Khovd, in collaborazione con lo studio locale UPI.
Si tratta in tutti i casi di “piani per la crescita” di queste cittadine con orizzonte 2030 : una sostanziale differenza con i piani italiani di governo del territorio, principalmente orientati al controllo e alla limitazione dell’espansione.
Ciò che si sta verificando in Mongolia è un’eccessiva confluenza della popolazione nella capitale Ulaanbaatar con il conseguente spopolamento di tutti i centri circostanti.
Se la ricca borghesia può permettersi di mandare i propri figli a studiare all’estero, per tutti gli altri la capitale mongola resta l’unica città nella nazione ad offrire servizi adeguati alla popolazione : ospedalieri, aeroportuali o per l’istruzione ad esempio.
Khovd è la più grande città della regione occidentale della Mongolia.
È Contraddistinta da un clima desertico e contornata da laghi, ma soprattutto la città è situata all’interno di un grande parco regionale – il Mankhan Nature Reserve – una zona classificata come strettamente protetta dal Governo mongolo (ospita peraltro esemplari del raro e protetto ghepardo bianco).
Il primo importante filo conduttore del progetto, nonché uno dei dettami del bando, è quindi il tema naturalistico.
Il progetto ha poi lo scopo di ristrutturare la città esistente, con la prospettiva di riuscire a raddoppiare l’attuale popolazione – 40.000 abitanti – dotando la città dei servizi basilari per i cittadini.
Kohvd si trova in una posizione geografica strategica tra Cina, Kazakhistan e Mongolia: valorizzare queste vie di interscambio deve essere la chiave per uno sviluppo economico competitivo.
Il masterplan individua tre aree: centro, strada del mercato e collegamento stradale. Ognuna è caratterizzata da una diversa atmosfera, ottenuta variando l’assetto stradale, l’organizzazione degli edifici, le funzioni, l’architettura, densità o l’altezza del tessuto urbano.

SF Restando sul filone Mongolia: avete realizzato, e state ancora realizzando, molti progetti di edilizia residenziale e turistico-ricettiva anche a Ulaanbaatar per la borghesia locale.
Si tratta di un buon esempio di export del brand Italia, inteso anche come modello di stile di vita.
Quali sono gli aspetti del made in Italy che avete reputato più importanti da trasporre in questa realtà così climaticamente e culturalmente diversa e perché?
B&LV I temi qui sono due: il primo è un tema prettamente strategico e il secondo è quello estetico.
La complessità del made in Italy permette di disporre di un’estrema ricchezza e varietà di materiale e tipologie da cui attingere per poter soddisfare offerte e bisogni di clienti dai gusti più disparati. Ogni area geografica ed epoca storica italiana offre tecniche, forme e materiali costruttivi differenti da cui prender spunto. Ognuna ha di volta in volta influenzato gli stili di vita e ha permesso di trasmettere messaggi precisi e adeguati alle necessità del tempo.
In Mongolia sono molto interessati agli elementi di decoro.
Diversamente dall’architettura come la intendiamo tradizionalmente, la struttura non partecipa alla definizione dell’estetica architettonica, la quale è affidata soprattutto all’ornamento e al suppellettile. Un fenomeno derivato dalla tradizione della gher – la tradizionale tenda per abitazione mongola (nda).
Per il progetto del centro commerciale e turistico ricettivo di Misheel Expo per esempio, noi architetti siamo stati chiamati ad intervenire solo in un secondo momento: a struttura già realizzata. Ecco allora che carte da parati, pavimenti, rivestimenti interni e di facciata diventano dettagli cruciali.
Considerare l’architettura in quanto elemento applicato a posteriori alla struttura, comporta spesso dei problemi tecnici di corrispondenza tra i due elementi, ma in questo caso si può lavorare con altri strumenti e seguendo esperienze che derivano dal teatro e dagli allestimenti di scenografia urbana: un’architettura che si adatta al corpo esistente, e ne diviene vestito, superficie.
SF “Questioni di facciata”: è il titolo della pubblicazione a cura di Moreno Gentili che sintetizza l’importanza e il simbolismo che riservate come progettisti a questo particolare elemento dell’edificio. La facciata è definita, per citare le vostre parole, come: “l’impronta sull’architettura della città che ogni nuovo intervento aggiunge.”
Volete spiegarci un po’ questo concetto?
B&LV Prima di tutto occorre precisare che si tratta di un libro concepito con l’intento di portare avanti una riflessione critica sul nostro lavoro, in un momento in cui per nostra crescita professionale, dovevamo e volevamo chiarirci i temi su cui avevamo lavorato e volevamo continuare a concentrarci.
La facciata ci è sempre sembrato l’elemento più forte e che arriva più rapidamente di un architettura. È il primo approccio visivo che si ha con un edificio, ed è proprio lei che gestisce la sequenza visiva di avvicinamento ad un edificio.
È sicuramente un elemento ambiguo, perché segna un confine: tra singolo edificio e collettività, tra privato e pubblico.
Essa veicola molti messaggi diversi, alcuni legati alla funzione dell’edificio, altri alla struttura, altri ancora più formali e simbolici.
Questo elemento ha inoltre la capacità di sintetizzare la storia di un edificio e il processo che l’ha prodotto.
Se osserviamo l’Ospedale degli Innocenti a Firenze che apparentemente si tratta di un progetto di facciata, e che segna per Brunelleschi il passaggio al linguaggio essenziale Rinascimentale. Tutti gli altri edifici sulla piazza, pur ospitando funzioni ben diverse, sono poi una trasposizione e una continuazione del progetto di quella facciata.
Questa è una dimostrazione di come la facciata abbia un ruolo cruciale nella trasformazione e nella definizione della qualità e del significato del paesaggio urbano circostante.
Infine un ultimo tema interessante è la trasformazione di questa pelle nel corso del tempo: il suo invecchiamento.
SF Alla fine della pubblicazione è presente anche uno scambio di domande e risposte con lo storico architetto milanese Vittorio Gregotti.
In cosa credete che il suo pensiero e il suo modo di fare architettura vi abbia ispirato maggiormente?
B&LV Noi ci siamo formati in un’ epoca in cui di veri grandi maestri non ce n’ erano più. Questo ci ha portato a considerare Gregotti come un valido modello da seguire non tanto per le sue architetture realizzate, ma per il suo approccio all’architettura. Il suo lavoro in continua connessione con la realtà universitaria e molti dei suoi scritti ci appaiono ancora oggi un duraturo stimolo alla professione e all’insegnamento.

SF Finiamo con un messaggio di speranza (speriamo) e parliamo di futuro.
Come professionisti e cittadini di Milano, quali cambiamenti vi attendete per la città in seguito all’EXPO 2015?
B&LV Per quanto riguarda l’EXPO 2015, siamo fiduciosi che si farà, e che comunque vada sarà un successo.
Un successo magari di dimensioni più contenute rispetto a quello che ci si aspettava all’assegnazione, e con un ritorno un po’ debole se consideriamo l’intero territorio della città di Milano.
Se il ritorno dell’evento si deve valutare sull’intera città, crediamo che questo sarà piuttosto debole, ma se si considerano delle specifiche aree della città, forse l’EXPO è stato il motore per vedere finalmente dei cambiamenti. Un esempio è la zona della Darsena e di Piazza 24 Maggio.
SF Mentre più in generale quali sono le vostre aspettative sul futuro in questo periodo storico così incerto?
B&LV Per quanto riguarda il futuro in generale, la situazione appare abbastanza grigia e ferma. Quello che si può e si deve fare è potenziare le relazioni internazionali, comprimere costi e spese per rimanere competitivi in un mercato in cambiamento, ma senza ovviamente comprimere la qualità dell’offerta.
Stefania Fiorentino
6 ottobre 2014

