Quando la laurea contava veramente
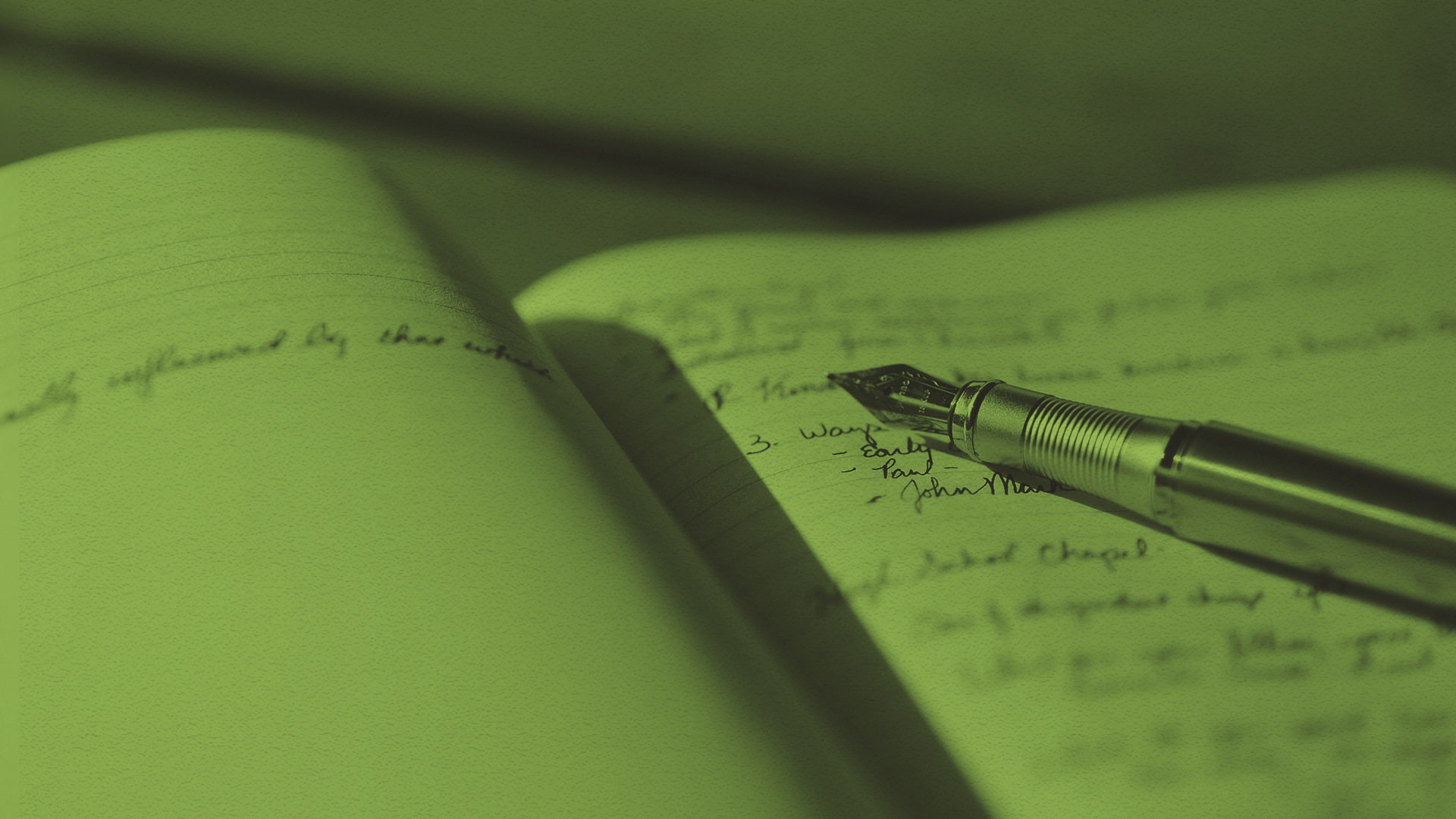
In cosa consisteva essere laureati, quando una laurea aveva ancora un enorme valore? Quella coroncina di alloro che gli studenti appena laureati indossano per goliardia, o per simbolo, ha un’antichissima tradizione; deriva da giochi atletici simili alle Olimpiadi.
L’Agone Certamen capitolino iovi è stato istituito nell’86 d.c. dall’imperatore Domiziano, l’Agone comprendeva una gara di musica, una gara equestre e una di ginnastica, per questo motivo era definito triplice, si teneva ogni quattro anni come le Olimpiadi. Svetonio nelle sue Vite dei Cesari racconta che Domiziano:
«Istituì una triplice gara quinquennale in onore di Giove Capitolino: musicale, ginnica ed equestre, e con un numero alquanto maggiore di premi di quanto non si usi oggi: A queste gare, infatti, prendevano anche parte i prosatori latini e greci, e oltre ai citaredi, anche i soli citaristi di accompagnamento, e i citaristi puri […] Ricostruì numerosissimi monumenti importanti […] Innalzò sul Campidoglio un nuovo tempio a Giove Custode, e costruì il Foro che oggi si chiama di Nerva, anche un tempio della gente Flavia, uno stadio, un auditorio musicale e una naumachia»[1].
I premi previsti da Domiziano per i vincitori erano senza dubbio adeguati all’importanza dell’istituzione. Tra le altre cose, oltre alla simbolica corona di quercia, una vittoria nel Certamen comportava la concessione della cittadinanza romana.
Nel tempo l’incoronazione poetica è divenuta una cerimonia simbolica tenuta in circostanze del tutto eccezionali a Roma in Campidoglio; questa, è un evento raro, un po’ come il miracolo per la religione o lo stato di eccezione per il diritto. Ispirata a rituali del mondo romano, l’incoronazione con una ghirlanda d’alloro, fu celebrata per Francesco Petrarca l’8 aprile 1341, poeta laureato per eccellenza. Lo stesso onore, la laurea, era stato concesso al padovano Albertino Mussato nel 1315 e il professore bolognese Giovanni del Virgilio lo aveva invano proposto a Dante Alighieri nel 1320.
Stando a due lettere al cardinale Giovanni Colonna, nel settembre 1340 Petrarca avrebbe ricevuto simultaneamente due proposte, dall’università di Parigi (il cui cancelliere era il fiorentino Roberto dei Bardi) e dal Senato di Roma, e avrebbe optato per la seconda alternativa (Familiares IV 4 e 5).
La cerimonia vera e propria ebbe luogo l’8 aprile, nel Campidoglio di Roma, e venne descritta da Petrarca in una lettera di poco successiva (Epystole II 1).
Inizialmente pronunciò il discorso che aveva preparato, la Collatio laureationis, esaltazione della funzione della poesia (da una citazione virgiliana: «Ma per le ardue solitudini del Parnaso mi trascina un dolce amore», Georgiche III 291-92) e delle qualità dell’alloro.
Quindi il senatore Orso dell’Anguillara lesse il Privilegium laureationis, discorso (steso almeno in parte dallo stesso Petrarca) che dichiarava il beneficiario storico e poeta (prendendo quindi in considerazione anche il De viris illustribus), gli concedeva il titolo di maestro e la facoltà di insegnare e lo rendeva cittadino romano. Infine Petrarca andò a deporre la corona d’alloro sull’altare della basilica di San Pietro.
Nel 1595 doveva svolgersi l’incoronazione di Torquato Tasso, ma il poeta morì prima della cerimonia. Lo stesso Tasso è esplicito al riguardo: «Qui in Roma mi voglion coronar di lauro», scrive al Granduca di Toscana il 20 dicembre 1594, «o d’altra foglia»[2].
Il 13 maggio 1725 avvenne quella dell’improvvisatore Bernardino Perfetti; scortato dalla principessa Violante di Baviera, moglie di Ferdinando de’ Medici e sua mecenate, il 13 maggio 1725, papa Benedetto XIII, lo incoronò Poeta Laureato in Campidoglio e gli concesse la cittadinanza romana.
Non solo poeti ma anche poetesse, il 31 agosto 1778, avviene quella di Corilla Olimpica[3], ovvero Maria Maddalena Morelli. Nel 1771 si stabilisce a Roma dove entra a far parte dell’Accademia romana dell’Arcadia con lo pseudonimo di Corilla Olimpica.
Il 16 febbraio 1775, in Arcadia viene indetta un’adunanza per promuovere la sua incoronazione in Campidoglio, a Roma, dietro le insistenze del suo mecenate (e amante) don Luigi Gonzaga, principe di Castiglione.
Nonostante le pressioni presso l’abate Pizzi, direttore della prestigiosa Accademia romana, e presso Papa Pio VI, il Gonzaga non riesce nell’intento, che tuttavia si concretizza grazie a un altro influente amante della Morelli. Così, il 31 agosto 1778, ottiene dal papa l’assenso all’incoronazione di Poetessa laureata e al conferimento del titolo di Nobile Romana.
Una cerimonia di incoronazione poetica è descritta da Madame De Staël nel suo romanzo Corinna o l’Italia, qui si può rintracciare una descrizione della cerimonia a cui assiste il protagonista Lord Oswald Nelvil; arrivato a Roma, la sua profonda amarezza non trova consolazione nella visita della città, non essendo incuriosito da niente, ma un giorno si imbatte nel singolare corteo trionfale che sta portando una donna all’incoronazione poetica in Campidoglio.
Viene a sapere che la donna si chiama Corinna e riesce a farsi notare da lei. Riconsegnandole la corona d’alloro cadutale dalla testa per una folata di vento, ne riceve un ringraziamento in un inglese privo di accento che lo stupisce.
È interessante riportate un lungo passo che può consegnarci l’atmosfera e una cronaca dell’evento.
«Si fermò questo carro al piè della scala, che conduce al Campidoglio, e in quel punto tutti gli amici di Corinna si precipitarono per offrirle la mano […] Ella salì le scale del Campidoglio la cui imponente maestà sembrava accogliere con benevolenza […] La musica si fece sentire con un nuovo strepito nell’istante dell’arrivo di Corinna: il cannone rimbombò, e la Sibilla trionfante entrò nel palazzo preparato per riceverla […] Nel fondo della sala era al suo posto il senatore che doveva coronarla e lo erano pure i Conservatori del Senato; da un lato tutti i cardinali e le donne le più distinte del paese, dall’altro i letterati dell’Accademia di Roma. La sedia destinata per lei era a uno scalino inferiore a quello del senatore. Corinna, prima di situarvisi, dovea, secondo l’uso, in presenza di quell’augusta assemblea, porre un ginocchio in terra sul primo scalino. Appena Corinna si assise i poeti romani cominciarono a leggere i sonetti e le odi che avevano composto per lei. Il Principe Castel Forte, lesse alcune parole in prosa, senza pretensione, ma singolarmente proprie per far conoscere Corinna […] Corinna si alzò quando il principe smise di parlare […] L’usanza vuole che il poeta coronato in Campidoglio improvvisi o reciti dei versi prima di ricevere sulla sua fronte i lauri […] E sentendosi animata dall’amore del suo paese, ella cantò versi pieni d’incanto e dei quali la prosa non può dare che un’idea molto imperfetta» [4].
C’era una volta la Laurea…
[1] Svetonio, Vite dei Cesari, Vol. II, Domiziano, Rizzoli, 2011, p.777.
[2] Lettere di Torquato Tasso, Firenze, Le Monnier, 1901, vol. V, p. 194.
[3] Atti della Solenne Coronazione Fatta in Campidoglio, della Poetessa M. Maddalena Morelli Fernandez, pistoiese, tra gli Arcadi Corilla olimpica, Stamperia reale Bodoni, Parma, 1779.
[4] Cfr., Madame de Staël, Corinna o l’Italia, Anna Eleanor Signorini e Michele Rak, Oscar Mondadori, Milano, 2006.




