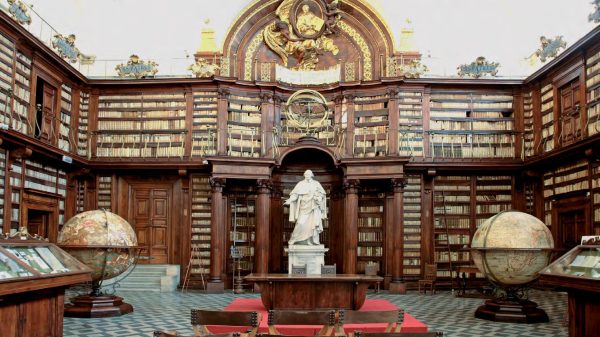Arcimboldo ovvero del grottesco naturale

Vissuto a cavallo della metà del Cinquecento (1526-1593), Giuseppe Arcimboldo, figlio d’arte (di Biagio) e milanese di nascita, fu pittore di gran successo, apprezzato per la sua produzione fantastica, tutta concentrata sulle famose “teste composite” e sulle “teste rovesciate”. Ispirato dal gusto del ritratto caricaturale, anche raccolto da Leonardo, Arcimboldo libera la sua immaginazione raccogliendo florilegi di animali, vegetali, oggetti d’uso, per farne gli ingredienti caotici dei suoi non-ritratti.
Apprezzato dagli Asburgo, per molti anni fu pittore di corte (per Massimiliano II e poi per il figlio Rodolfo II), prima a Vienna e poi a Praga. La riscoperta delle sue opere, tutte caratterizzate dal gusto del grottesco, della bizzarria, risale al XX secolo, quando il surrealismo degli Anni Venti (che ebbe in André Breton il suo teorico, e in Max Ernst, Salvador Dalì, René Magritte, Joan Mirò, alcuni dei suoi più illustri rappresentanti nella pittura) vi credette di trovare un precedente storico.
Le opere più celebri di Arcimboldo sono infatti, sempre e comunque, allegorie, rappresentazioni quasi ideologiche di un tema, più e più volte ripetuto in varianti più o meno celebri: anche per esigenze di mercato, giacché i suoi mentori e protettori, gli Asburgo, usavano regalare, per ragioni diplomatiche, copie delle opere di Arcimboldo che oggi si trovano nelle collezioni delle ex-monarchie europee.
Tuttavia i suoi quadri sembrano più che altro variazioni sul tema (delle ‘teste’), forse inizialmente nate per rispondere all’appetito per il grottesco, caratteristico della sua epoca. Ad inizio del Cinquecento sono ‘tornati a casa’ Bartolomeo Diaz (dall’Africa Australe), Cristoforo Colombo (dal Nord America), Amerigo Vespucci (dal Sud America), mentre Ferdinando Magellano sta per cominciare la sua avventurosa circumnavigazione. L’Europa delle monarchie e della borghesia inizia così a conoscere l’esotismo, la diversità: specie animali e vegetali irriconoscibili, stravaganti, colorate, spesso scambiate anche (o frammischiate) con dei falsi, dei ‘montaggi’ tassidermici frutto non di paesi lontani ma delle botteghe artigiane più disoneste.
La diversità viene comunque percepita come ‘bizzarria’, il mondo si scopre concretamente molto più grande, soprattutto si allarga a dismisura quella parte di mondo che diventa ‘percorribile’, raggiungibile, e che diventerà poi colonia e suddito. Alla curiosità si affianca l’inquietudine, fioriscono i trattati di zoologia e botanica, che cercano di ricondurre nell’alveo della Scienza la confusione che inizia ad intuirsi nel Creato.
In questo senso nel ‘non-ritratto’, ovvero le “teste” di Arcimboldo è ipotizzabile– tra l’altro – un forte contenuto ideologico: non si tratta, evidentemente, di una pittura con finalità di memoria storica o di celebrazione dei suoi soggetti umani, giacché i personaggi non hanno e non possono avere nessuna somiglianza, nessuno spessore psicologico.
Piuttosto sembra alludere alla figura umana (il ritratto, cioè viso, bocca, naso, occhi…) come risultante di una molteplicità, una bizzarria, una confusione – altrimenti disarmante – di animali, piante, fiori, oggetti d’uso. Come a dire che Arcimboldo trasforma il ritratto nella “summa naturae”, quasi indicando l’uomo come esito ultimo della varietà della creazione, ed è forse anche un modo per rendere umano e normale quello che è diverso e multiforme. Dalla trama inspiegabile del regno animale e vegetale emerge l’unica possibile conciliazione, il ritratto umano. Dal 1562 al 1576 a corte (tra Vienna e Praga), in fondo Arcimboldo in questo ha trovato (o esteso) uno spunto felice, ed ha creato un genere, all’epoca di successo.
Arcimboldo segue di quasi un secolo il ‘pittore della bizzarria’ per antonomasia: Hieronymus Bosch, maestro olandese (1453-1516). Abilissimo nell’affollare con ironia i suoi quadri di ibridi e commistioni umano-vegetali e umano-animali: le inquietanti, minuziose visioni di Bosch – all’opposto di Arcimboldo – trascendono la realtà, la frammentano in un caos, in una danza elegante quanto angosciante (si veda “Il trittico delle Delizie”), in cui i ‘pezzi’, strumenti musicali, uccelli e piante, e soprattutto anime dannate, si mescolano e si ricombinano caoticamente, laddove il Nostro milanese.
La mostra di Arcimboldo (sei sale, circa una cinquantina di pezzi autografi), soprattutto per la provenienza dei suoi pezzi si pone come una buona occasione per farne la conoscenza diretta, contribuendo a tracciare – come si è detto – quei fili ideali che ne legano l’arte istrionica al passato Quattrocentesco così come al Surrealismo che verrà poi.
Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini
Roma, via delle Quattro Fontane, 13
20 ottobre 2017 – 11 febbraio 2018
ORARI
martedì, mercoledì, giovedì e domenica: 9.00-20.30 (ultimo ingresso ore 19.30)
venerdì, sabato e festivi infrasettimanali: 9.00-22.00 (ultimo ingresso ore 21.00)
Prenotazioni: 06 81100257
http://www.barberinicorsini.org